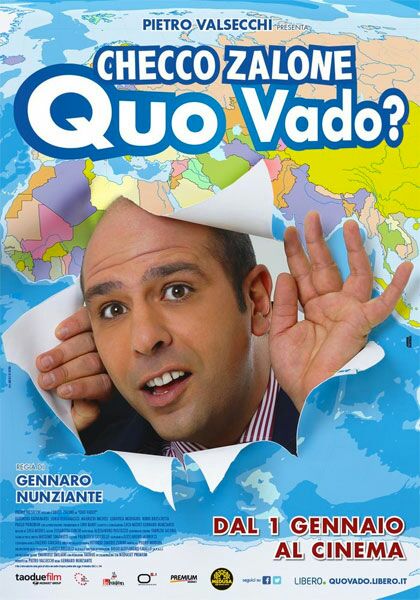Ipse dixit: <<Non credo stiano elevando il genere ad una forma d’arte. Penso che Batman resti un tizio che corre in giro con uno stupido mantello>>. Per quanto ci si possa sforzare, per quanto si possano avere i migliori propositi realizzativi, un buon regista deve pur sempre fare i conti con dei sanissimi e salvifici stereotipi cinematografici. E se ad illuminarci a riguardo è il miglior regista vivente, ossia David Cronenberg, l’opinione trova un precedente illustre. Il maestro canadese parlava in quella famosa intervista dei cosiddetti cinecomics, vale a dire film tratti da fumetti, smontando nel caso specifico ogni tesi che inneggi ai Batman di Nolan come fossero dei capolavori indiscussi, impregnati di una (solo presunta) nuova forma di autorialità. <<Son sempre fumetti!>>, chioserebbe dunque il dissacrante David.
E approfittiamo della disputa innescata da questa nobile considerazione per parlare oggi di una “pellicola” che tutto il mondo ha osannato, vale a dire Inside out. Piaciuto ai bambini perché disegnato e fotografato brillantemente, ai grandi perché molto più profondo di quegli odiosissimi e diseducativi pupazzi gialli che hanno invaso il mondo. Piaciuto, aggiungiamo noi, perché semplicemente originale. In un’epoca infatti di miserrimo e mediocre appiattimento monodimensionale in ogni ambito artistico, basta un’idea inusuale per stupire, indipendentemente da come essa venga poi strutturata e realizzata. E le aspettative su questo film d’animazione erano delle migliori: un film che indaghi la mente di una ragazzina in un’età delicata come quella prepuberale non è di certo robetta da poco! Ma come spesso accade, le grandi produzioni si cullano sugli allori di un soggetto da urlo per accontentarsi poi di sceneggiature aporetiche. Ed è il caso proprio di questo film, il quale, se dal canto suo propone un’elevazione a statuto analitico e psicologico della classica animazione, frana in delle voragini che inevitabilmente le alte pretese apportano. E se lo si considera come un’elevazione del genere (come si pretendeva che fossero i Batman di Nolan), allora rispetteremo questa etichetta e applicheremo un’analisi metodologica, strutturale e persino filosofica al film.
In primis. Ciò che più fa raggelare durante la visione anche solo superficiale di tale film è la scioltezza apparentemente disincantata nel presentare le varie funzioni cerebrali e le emozioni base come se fosse una descrizione sacrosanta. È come se il film insomma poggiasse sul trono dell’indiscussa verità suprema, solo perché ricco di riferimenti dedotti dalla scienza ufficiale. Inside out appare come una sorta di documentario scientifico romanzato e cartonato, per questo apprezzabile e intrattenente. Ogni sequenza, seppur stilizzata e limata per apparire gradevole o sorprendente, risulta essere una sorta di indottrinamento accademico e didascalico. Ricordate quella collana di videocassette che più di un decennio fa usciva periodicamente in edicola finalizzata ad illustrare come funzionasse il nostro corpo? Bene, Inside out sembra un’appendice di questa collezione, il cui scopo principale è celato sotto le mentite spoglie della formazione di una bambina che non è più tanto bambina. Il tutto imbellettato da una confettura dolcissima e patinata al punto giusto che solo la Pixar sa garantire.
Ma l’intento didascalico non avrebbe nulla di riprovevole dalla sua, se non la sua componente esclusivamente scientifica. O, potremmo aggiungere, positivistica! Perché le dinamiche interne alla mente della povera ragazzina sembrano non lasciare nulla al caso. Movimenti, azioni, parole e reazioni sono il frutto di combinazioni meramente algoritmiche (peraltro quasi mai chiarissime), come fossimo computer, macchine. Già, i rapporti meccanici sono i prediletti per regolare la combinazione di varie dinamiche organiche e le varie relazioni funzionali. Ciò che Cartesio, secoli fa, è riuscito (ahinoi!) ad inculcare nella già lacera cultura occidentale, è oggetto di (ri)valutazione da parte degli Studios americani. Ciò che si critica del film in questa sede non è dunque solamente la trama in sé o la sovrastruttura dettata dalla sceneggiatura, ma le fondamenta culturali, le impostazioni di base, l’orientamento deontologico del regista. In altre parole, come il filosofo francese nel XVII secolo guardava al corpo umano come ad una poco nobile accozzaglia di componenti tra loro strettamente connesse e regolate da rapporti di causa ed effetto, allo stesso modo Pete Docter esclude ogni possibilità di connessione teleologica (orientata cioè da e ai fini umani, in questo caso intellettivi) tra le parti, le emozioni. Ma una tale radicale presa di posizione è mitigata dalla fattura estetica delle emozioni base: esse difatti sono animate e hanno una coscienza, ma non perché si voglia dare un aspetto più intimo e meno dogmatico al film, quanto più perché è un film d’animazione, e i protagonisti devono necessariamente avere una forma, un nome, un verbo; devono essere personificati. Qualcuno obietterà alle nostre posizioni ribattendo che, in alcune sequenze, la ragazzina si emancipa da quell’involucro robotico di latta che sembra ingabbiarla per tutto il film. Ci riferiamo alle scene in cui Allegra e Tristezza vengono catapultate nella labirintica memoria a lungo termine e lì si perdono. Ma analizzando a fondo, anche in quei casi l’”androide” Riley non fa altro che attivarsi o disattivarsi ai comandi delle restanti emozioni base o proseguire nei suoi piani esclusivamente per inerzia, seguendo le istruzioni precedentemente datele.
In seconda battuta, proseguendo sulla falsa riga di quanto dedotto dalla prima analisi, passiamo ad una critica più strettamente extracinematografica. Senza assumere una visione dietrologica e complottistica, diciamo subito che è in corso una campagna mondiale di condizionamento ideologico che passa per il maggior medium di massa, nonché il più pericoloso, cioè Hollywood. Esso prevede di inculcare, sotto le mentite spoglie di generi apparentemente innocui (come i film d’animazione) o di generi nobilissimi (come la fantascienza), una avanguardistica, progressista ma essenzialmente fascista visione dell’uomo. Essa prescinde da ogni forma di provvidenzialismo fideistico, da ogni approccio religioso per approdare ad una (solo presunta) matura condizione superomistica. E il biglietto da visita per raggiungerla è di certo una sconfinata fiducia nella scienza che tutto vede e tutto può. Ciò insomma che per secoli ha rappresentato di volta in volta un infuocante pretesto per confutare ogni tesi di matrice religiosa, diviene oggi la quintessenza del bigottismo scientista, della ben più cieca presunzione dogmatica odierna. Non ci rendiamo conto insomma di parlare come computer programmati, convinti di possedere la verità tra le mani, ma in realtà influenzati e terribilmente condizionati dall’effusione di uno spirito tutt’altro che santo, mediaticamente indotto. L’anticonformismo razionalista diviene all’improvviso semplice divulgazione di massa, appiattito e uniforme. Merito di film apparentemente ininfluenti a livello ideologico, ma invece subdolamente attivissimi. E quale sarebbe il fine di film come questi? Dirigere le masse verso una concezione del corpo automatica, quasi tecnologizzata. Si inizia con l’influenzare tutti sul piano bioetico: se il corpo appare come una macchina, allora si può rimettere a nuovo e riparare come una macchina, sostituendo semplicemente un pezzo con un altro (sia essa chirurgia organica, sia essa chirurgia plastica), dimenticando che una delle proprietà primarie del nostro organismo è quella della relazione finale tra le parti; per arrivare poi alla considerazione finale, nociva: se il corpo funziona e si ripara come una macchina, allora può essere assimilato ad una macchina. Da qui uno spietato proselitismo a favore dell’intelligenza artificiale e della tecnologia in generale, che ne rappresenta l’anima. Immediatamente e quasi inconsciamente, tutto il mondo assume un punto di vista traviato, concependo questa congruenza tra mondo meccanico e mondo organico come un’inevitabile evoluzione dettata dai tempi. E riaffiora alla mente l’immagine del corrotto e manipolato corpo dei protagonisti di Crash, del già citato Cronenberg. E non rappresenta mica uno spocchioso delirio intellettualistico la nostra citazione! Perché film come Inside out, alla lunga, sono funzionali ad abbassare notevolmente la soglia dello stupore nel mondo di oggi. Così che nemmeno i protagonisti di quell’estremo e meraviglioso film del buon David possano più impressionarci o provocarci disgusto, dato l’ingresso a pieno titolo di quei “caratteri” nella cronaca di ogni giorno e nell’immaginario etico collettivo. Corpi perforati, meccanicizzati, lubrificati come giunture di un motore o rattoppati approssimativamente non destano più sconcerto oggigiorno. Perché, anziché essere scongiurato, tutto ciò è paradossalmente divenuto la nuova frontiera dell’esistenza. Tirata per lunghe, eccessivamente. Stirata oscenamente e spremuta come un limone. In quel mortifero connubio tra tecnologia protetica, fascinazione erotica meccanica e… decesso.
L’unica cosa che ci auspichiamo succeda è che nel sequel si parli un tantino di più della povera bambina, anziché delle sue ignobili e “impersonali” funzioni. Si spera dunque che le delicatissime trame della fase puberale cui Riley è approdata siano trattate più umanamente, senza franarci sopra con onnisciente smania dogmatica, e che lo sviluppo delle vicende non sia affidato solamente a comandi incontrovertibili ma anche a dinamiche non rispondenti a logiche stringenti e non così facilmente delucidabili. Si riparta, per realizzare un buon sequel, dall’unica vera nota positiva del film, vale a dire il personaggio di Tristezza, intesa come l’unica reale fonte di ispirazione, di rilancio, di reazione alla balorda vita. Da essa scaturisce il dolore che ci permette, ancor più dell’incondizionata e per questo odiosissima e intollerabile Gioia, di affrontare con determinazione le difficoltà. Da essa scaturiscono persino cultura, acuta intelligenza, dominio di sé e la migliore delle qualità, l’umiltà. Si riparta persino da Rabbia, identificata saggiamente come un surrogato trasfigurato dell’orgoglio. Si riveda, invece, l’emozione base della Paura, troppo approssimativamente ritratta (che rimanda più all’immagine della Codardia). Sospendiamo dunque, per il momento, il giudizio sul film e il regista, attendendo notizie sulla seconda parte e augurandoci che, ritentando, Pete Docter possa essere più fortunato. Altrimenti ci arrabbiamo!
Detto ciò, voi direte: <<Ma perché accanirsi così tanto e così pedantemente su questo film? È pur sempre un cartone!>>. Esatto, è qui che vi volevo: son sempre cartoni! Ma solo dal punto di vista strettamente artistico. Perché celano in verità (e più di quanto diano a vedere) messaggi massimalisti. Che nemmeno il buon Cronenberg, questa volta, dovrebbe sottovalutare.
Gabriele Santoro
Leggi tutto